La libertà non basta: se non è consapevole, non libera nessuno
Dal concetto di liberazione alla libertà interiore: perché oggi servono cultura, pensiero critico e nuove domande.
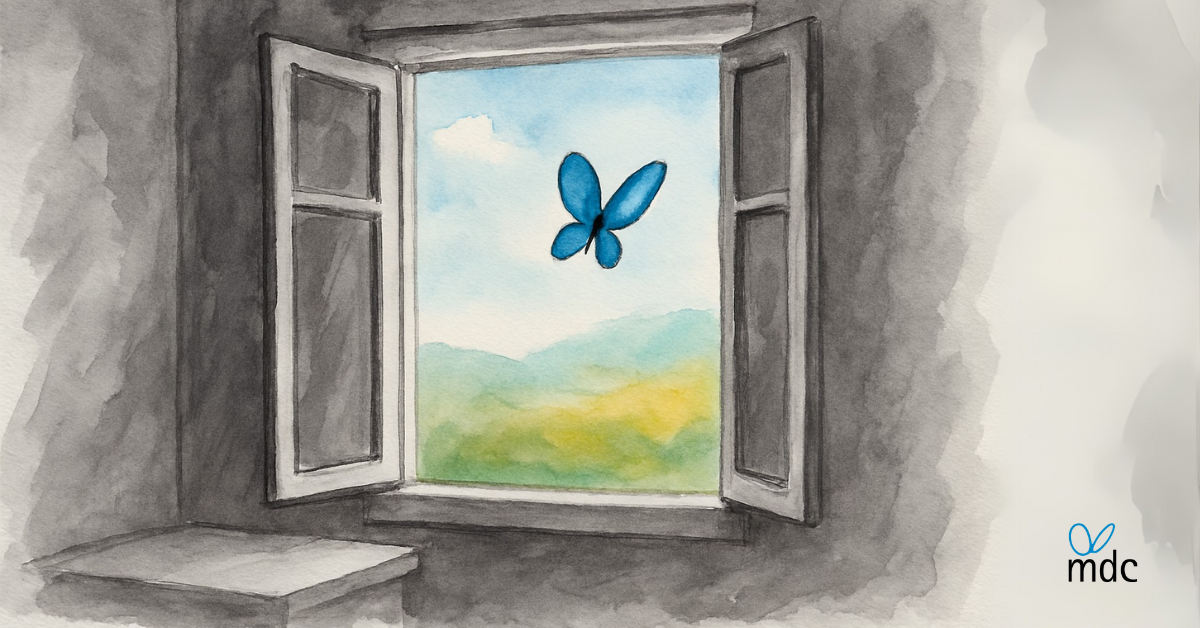
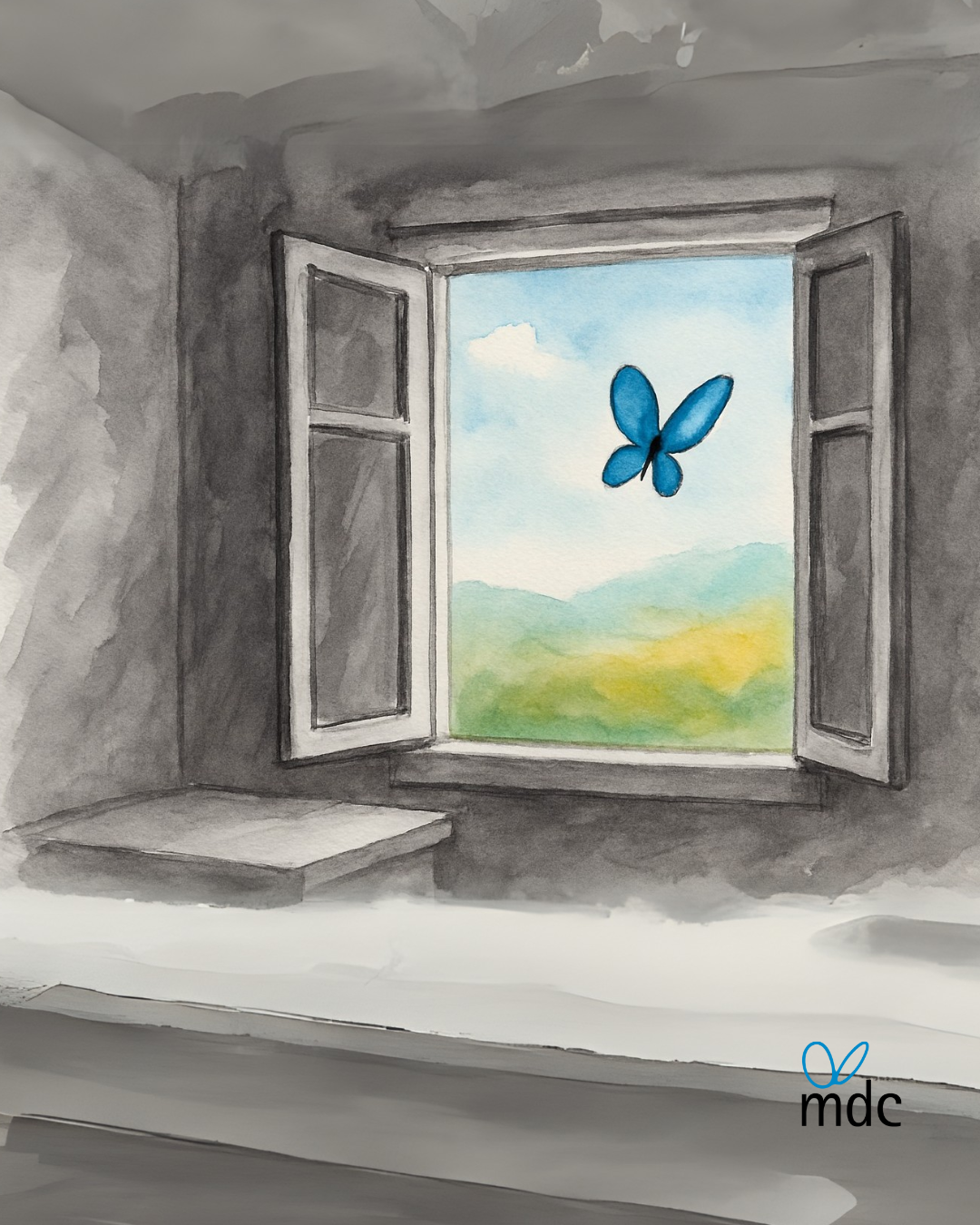
Il 25 aprile celebriamo la Liberazione. Che non è solo un evento storico, ma anche un’occasione per riflettere sul concetto da cui deriva: la libertà.
Tutti noi pensiamo di sapere cosa significhi e che valore abbia, ma è la parola stessa a presentarci un primo tranello sintattico: in Programmazione Neuro Linguistica diremmo che siamo di fronte ad una nominalizzazione, cioè ad un sostantivo usato in modo anomalo per connotare un processo, e non una cosa. Il risultato è un’illusione: il cervello maneggia la parola come se fosse una cosa vera, in carne ed ossa, e non si pone il dubbio se il significato che le sta attribuendo sia il medesimo di chi l’ha pronunciata.
Chi è libero? Rispetto a chi o a cosa? Libero di fare cosa? E in che modo?
Sono tutte domande che verrebbero spontanee se usassimo il verbo, e che aprirebbero un mondo di risposte individuali che metterebbe in serio dubbio il significato condiviso di questo valore.
Libertà deriva dal latino liber, che indicava originariamente chi era libero, privo di vincoli o costrizioni. Ma, come accade spesso, le parole si evolvono e prendono significati diversi, sfumature che non sempre coincidono. La libertà politica, la liberazione, è un atto collettivo che riguarda la fine di un regime oppressivo. La libertà economica, incarnata nel liberismo, riguarda la possibilità di agire senza ingerenze esterne, ma con il rischio di un’eccessiva disuguaglianza. Il libertinismo, invece, ha preso una piega completamente diversa, portando l’idea di libertà al suo estremo, dove il rifiuto di qualsiasi limite diventa un comportamento che travalica l’etica. C’è poi la libertà che sperimentiamo nel nostro quotidiano, che potremmo definire “psicologica”. Essa parte dalla consapevolezza di sé e dei propri criteri di vita, consapevoli del fatto che siamo necessariamente anche frutto dei condizionamenti del nostro contesto.
Nel giorno in cui celebriamo una liberazione storica, possiamo anche fermarci a riflettere su quali sono le prigioni invisibili in cui spesso ci troviamo oggi. Non ci sono più catene, ma restano condizionamenti culturali, lacci relazionali, pensieri automatici, paure interiori. E allora vale la pena chiederci: cosa significa davvero essere liberi nel nostro presente?
Libertà, democrazia e ghigliottina
di Andreas Schwalm

Quando si parla di libertà, ci si muove su un terreno complesso. Non esiste “la” libertà in astratto: esistono modi diversi di pensarla, viverla, difenderla.
Isaiah Berlin ci offre una distinzione fondamentale: la libertà “da” e la libertà “di”. La prima è l’assenza di costrizioni esterne, la seconda è la possibilità concreta di agire, di realizzarsi. Senza la prima, siamo schiavi. Senza la seconda, siamo paralizzati. Alcuni di noi si concentrano sulla prima (mentalmente hanno un orientamento “via da”), altri sulla seconda (hanno un orientamento “verso” un risultato): eppure l’una senza l’altra sono incomplete. Questi orientamenti interiori influenzano anche il nostro modo di concepire la libertà politica: alcuni temono lo Stato che impone, altri desiderano uno Stato che abilita.
Se facessimo un viaggio nel tempo nelle polis dell’antica Grecia, scopriremmo che essere liberi non significava “fare ciò che si vuole”, bensì partecipare alla vita politica della città. La libertà era concepita come appartenenza attiva alla comunità. In nome della libertà della polis, si poteva limitare fortemente la libertà dell’individuo. Come accadde a Socrate, condannato a morte perché considerato pericoloso per la coesione morale della città. In quel sistema, l’autonomia del pensiero era vista come una minaccia alla libertà collettiva.
Da questo filone prende vita il pensiero di Rousseau, che ha ispirato la Rivoluzione Francese, dove la libertà coincide con l’appartenenza alla comunità e con l’obbedienza alla sua volontà generale. Una visione affascinante, ma che può degenerare in quella che Tocqueville chiamava “la tirannia della maggioranza“. E nella ghigliottina.
Da qui nasce una tensione ancora attuale: come garantire una libertà condivisa senza sacrificare quella individuale?
L’idea che oggi abbiamo di libertà è associata ad un’altra parola: democrazia. Ma democrazia non è sinonimo automatico di libertà: esiste solo quando è democrazia liberale, cioè uno stato che tutela i diritti di tutti. E il modo migliore per farlo – anche se imperfetto – è la separazione dei poteri.
Celebrare la Liberazione significa allora ricordare che la libertà non è solo una conquista individuale o interiore: è anche e soprattutto una responsabilità collettiva, che richiede cultura, vigilanza e un pensiero critico sempre acceso.
La libertà non è un traguardo, è un mindset
di Camillo Sperzagni

Molte persone – specialmente i più giovani – sono inclini a pensare che essere liberi significhi semplicemente poter scegliere e agire a piacimento. Ma ogni scelta in realtà nasce dentro una rete fitta di condizionamenti: la nostra storia personale, le paure che ci abitano, i modelli che abbiamo interiorizzato. E poi ci sono le aspettative degli altri, le richieste implicite dell’ambiente, i vincoli che ogni contesto ci impone.
Perciò, essere liberi significa prima di tutto diventare consapevoli di ciò che ci guida, ci limita, ci influenza. Significa imparare a distinguere ciò che vogliamo davvero da ciò che ci è stato insegnato a volere.
In questo percorso, strumenti come la Programmazione Neuro-Linguistica (PNL) e l’approccio sistemico possono fare la differenza. La PNL ci aiuta a riconoscere i meccanismi linguistici e mentali con cui costruiamo la nostra realtà: come formuliamo i pensieri, che domande ci poniamo, che immagini mentali utilizziamo. L’approccio sistemico, invece, ci insegna a vedere noi stessi non come individui isolati, ma come parte di reti relazionali complesse: famiglia, lavoro, società. La loro combinazione ci può aiutare non solo per essere efficaci nel contesto in cui ci muoviamo, ma soprattutto come strumenti per coltivare la propria consapevolezza e, poco alla volta, costruirsi un mindset nuovo: quello di chi coltiva libertà dentro e attorno a sé.
Perché la libertà non è un’assenza di limiti, ma la capacità di muoversi con lucidità dentro quei limiti, allenandoci a riconoscerli, vederne la struttura, a superarli e ad affrontarne di nuovi: questa è la Libertà a cui possiamo davvero aspirare. Che non si conquista in un colpo solo: si costruisce, una consapevolezza alla volta. Certo, un percorso destinato a non avere mai fine. Ma che ben presto ci aiuterà a smettere – una buona volta – di essere schiavi senza nemmeno accorgercene.
Una missione per coach che sanno esplorare
di Valentina Ferrari

Il valore della libertà è così grande e universale che è quasi impossibile trovare qualcuno che non lo annoveri fra i suoi preferiti. Alla fatale domanda: “cosa è importante per te?” che noi coach, con poca fantasia, poniamo ai nostri coachee, è quasi automatico che la libertà sia la risposta.
Spesso è la prima in classifica e quando non lo è, viene comunque nominata. Non si vorrebbe offenderla e quindi, se capita di dire, ad esempio: la fedeltà, subito ecco che ci si aggiunge subito la libertà. Non sia mai che si possa sembrare troppo rigidi, meglio affiancarla sempre, tanto lei – la libertà – sta bene con tutto.
Un po’ come il bianco, no? In fondo, è il suo colore. Mettersi a trovarle significati che non siano già stati scritti è difficile e abbastanza inutile. Tornando alle nostre domande poco fantasiose e alle altrettanto poco creative risposte dei nostri coachee, forse possiamo provare ad esplorare una via che ci potrebbe tornare utile. Il senso che la libertà ha per chi ce la porta durante una sessione di coaching. Come si declina la libertà per lei/lui? Che significato ha davvero? Dove incomincia la libertà? Quando?
A qualcuno verrà da sorridere, ma proviamo davvero a riflettere non accontentandoci di risposte confortanti a domande banali. Il coaching è molto di più che l’individuazione di un obiettivo e dei compiti di comportamento. Se il coachee ci parla di libertà, e probabilmente lo farà prima o poi, possiamo permetterci di esplorare. Cosa ci vuole dire? Cosa desidera esprimere attraverso il concetto di libertà?
Se crediamo nella libertà, vogliamo qualcosa. Un comportamento, un obiettivo, un desiderio. La libertà va sempre verso. A noi coach il compito di scoprire dove. Senza paura di esplorare.

